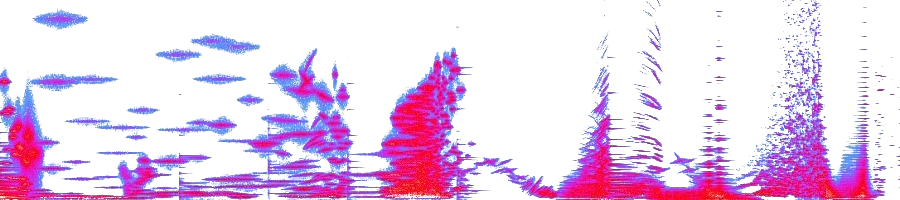Su Repubblica del 10 novembre 2006, in occasione della presentazione di “Brawlers, bawlers and bastards”, il nuovo triplo cd, era uscita un’intervista con Tom Waits breve, ma così bella che non riesco a resistere alla tentazione di riportarla.
Tom parla nel modo che mi è sempre piaciuto: facendo poesia (la descrizione finale della vita è grandiosa). Una cosa che riesce a pochissime persone (uno grandioso in questo era William Burroughs).
In ogni caso riconosco che la proprietà dell’intervista è di Repubblica e dell’autore, Giuseppe Videtti. Mi impegno fin d’ora a toglierla dietro semplice richiesta via mail.
Pensate però che questa vostra bella pagina ormai è finita nel dimenticatoio perché, come dicevano i Rolling Stones, “who wants yesterday’s papers?”. Così, almeno, un po’ di gente la legge di nuovo…
Ecco l’intervista. Godetevela ascoltando Bottom of the world, il brano diffuso in internet come trailer del disco.
Lei dice di scrivere canzoni che, a volte, non vogliono essere cantate.
“Incidere una canzone è come catturare un passero: devi farlo senza rischiare di ucciderlo. A volte per la fretta di trasferire una canzone su disco ti resta in mano con un pugno di piume, e il passero, cioè la canzone, è volato via”.
Quando capisce che è il momento di cantare questa o quella canzone?
“Le canzoni hanno una loro gestazione, alcune hanno urgenza di essere diffuse, altre vogliono restare nell’ombra e continuare a cambiare col tempo. La canzone ha una tradizione millenaria, l’industria discografica, al contrario, ha appena cent’anni di vita. Per secoli le canzoni sono state tramandate oralmente. Nessuno può assicurarci che i brani “popolari” sono giunti a noi nel modo in cui furono scritti in origine”.
Qual è stata la prima volta che una canzone le ha attraversato la mente e le ha fatto desiderare di essere un cantautore.
“Quando mio padre mi cantava le arie messicane accompagnandosi con la chitarra. Dovevo avere 4 anni, non di più. Poi arrivò Harry Belafonte e fu amore al primo ascolto. Anch’io sono sempre stato attratto da culture “altre”, la mia musica nasce dalla lotta d’influenze inconciliabili fra loro. Mi piacciono Judy Garland e Black Flag, Frank Sinatra e Sex Pistols, mariachi, rumba, bossa nova…”.
E tango…
“Molto tango… una volta alla radio si ascoltava di tutto, quella è stata la mia scuola. Non ero io che scoprivo la musica, erano quelle canzoni che mi cercavano. Da adolescente ascoltavo il leggendario dj Wolfman Jack, fu lui a spalancarmi gli occhi sulla black music, poi finii in una scuola superiore frequentata in massima parte da neri, e allora scattò la scintilla per James Brown e tutta la musica nera. Che bei tempi, quanti talenti. Oggi l’industria è piena di bugiardi e disonesti. Cercano di convincere il primo venuto che sarà il prossimo Elvis, questo è l’inganno; poi se non vende subito lo buttano via come un barbone, anche se è un genio”.
Com’era l’industria quando lei esordì, negli anni 70?
“C’erano sciacalli e pescecani, come oggi, ma anche a personaggi naïf come me veniva offerta una chance”.
Vuol dire che aveva una dose sufficiente di creatività?
“Creatività? Sì, e molti desideri e sogni, ma ero anche giovane e stupido. E molto fragile, e a qualcuno questa mia fragilità piacque, e decise di proteggermi facendomi incidere un disco. Ma a quel punto ebbi bisogno di un manager e, come succede a tutti, fui frodato”.
A lei fu data la possibilità di continuare a incidere.
“Ognuno vive il suo tempo, io esordii in un periodo in cui l’industria cercava di fertilizzare le uova che aveva nel pollaio. Oggi iPod, Mp3 e Internet hanno atrofizzato l’interesse del pubblico, anche gli artisti hanno perso quel senso d’avventura che ci spingeva a sperimentare. Quel che mi consola è che, nonostante tutto, c’è ancora voglia di suonare dal vivo; la musica continua a essere un bisogno primario”.
Non c’è da essere pessimisti con 33 anni di carriera come la sua.
“Ogni cosa ha il suo prezzo. Fin dall’inizio sapevo che non volevo arrivare a 24 anni e odiare la musica, sapevo che c’erano meccanismi che non mi piacevano e un certo tipo di pop che non avrei mai voluto fare. La mia longevità ha a che fare con una sorta d’integrità che, ovviamente, ha richiesto dei sacrifici economici. Sa come va la storia, no? La tua foto sui giornali diventa sempre più piccola, le recensioni dei tuoi dischi sempre più brevi. Ma è ok, non ho mai pensato di diventare come Beatles e Rolling Stones”.
Che successe nel 1983, quando con Swordfishtrombones diede un taglio netto al passato?
“Mia moglie e io volevamo produrci il disco da soli, sapevamo che era un album diverso, ma tutti volevano che io rimanessi lo stesso, neanche fossi la ricetta di un soft drink. Mi trattavano come una 7Up, io invece ero alla ricerca di qualcosa che non riuscivo a trovare dentro di me. Kathleen diceva: “I tuoi dischi suonano come se avessi sul viso una maschera”, voleva che somigliassi di più a me stesso”.
Cosa la colpì di Kathleen all’inizio, la donna o l’artista?
“La donna. Se non ci fosse stato amore non saremmo ancora insieme dopo 26 anni. E mi creda, collaborare con qualcuno che ami è la cosa più bella. Noi due siamo come la ciurma di una nave, devi saper cucinare, riparare, rammendare, governare, nuotare. La nostra è una grande cucina”.
Sua moglie dice di lei che è l’uomo più testardo che abbia mai conosciuto.
“È vero, è difficile farmi cambiare idea, anche se la paternità mi ha fatto diventare più… malleabile. Il vero matrimonio indissolubile è quello con i figli (io ne ho tre, il più grande suona con la mia band), da loro non puoi divorziare. Riesco a mantenere la calma anche quando mi chiedono: “Hey pa’, puoi trovarmi un paio di biglietti per il concerto dei Red Hot Chili Peppers?””.
Come scorre la sua vita in mezzo a tutto questo silenzio?
“Diversa ogni giorno. È come stare sulla torre di controllo di un aeroporto: momenti di noia mortale, momenti di terrore assoluto. A volte la barca è piena di pesci, a volte sei in cerca della tua fede nuziale in fondo all’oceano, a volte il vento soffia così forte che quasi ti strappa la pelle dal viso, a volte sorseggi un limonata sul bordo della piscina. Qualche volte si fa festa, altre volte c’è carestia: in mezzo il nulla. A volte, come diciamo noi americani per dire che diluvia, piovono cani e gatti, altre volte anche tori, mucche e topi. E qualche volta la mia vita galleggia su un petalo di giglio”.