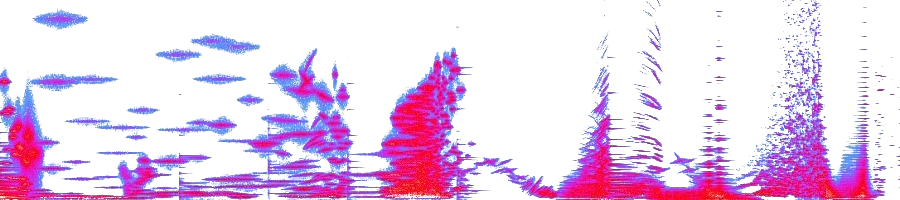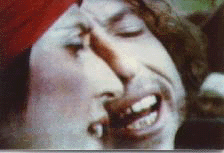“C’è un quadro di Klee che si chiama Angelus Novus. Vi è rappresentato un angelo che sembra in procinto di allontanarsi da qualcosa su cui ha fisso lo sguardo. I suoi occhi sono spalancati, la bocca è aperta, e le ali sono dispiegate. L’angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Là dove davanti a noi appare una catena di avvenimenti, egli vede un’unica catastrofe, che ammassa incessantemente macerie su macerie e le scaraventa ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e riconnettere i frantumi. Ma dal paradiso soffia una bufera, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che l’angelo non può più chiuderle. Questa bufera lo spinge inarrestabilmente nel futuro, a cui egli volge le spalle, mentre cresce verso il cielo il cumulo delle macerie davanti a lui. Ciò che noi chiamiamo il progresso, è questa bufera”
“C’è un quadro di Klee che si chiama Angelus Novus. Vi è rappresentato un angelo che sembra in procinto di allontanarsi da qualcosa su cui ha fisso lo sguardo. I suoi occhi sono spalancati, la bocca è aperta, e le ali sono dispiegate. L’angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Là dove davanti a noi appare una catena di avvenimenti, egli vede un’unica catastrofe, che ammassa incessantemente macerie su macerie e le scaraventa ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e riconnettere i frantumi. Ma dal paradiso soffia una bufera, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che l’angelo non può più chiuderle. Questa bufera lo spinge inarrestabilmente nel futuro, a cui egli volge le spalle, mentre cresce verso il cielo il cumulo delle macerie davanti a lui. Ciò che noi chiamiamo il progresso, è questa bufera”
[W. Benjamin “Tesi sul concetto di storia” (1940) Einaudi, Torino 1997, pp. 35-7]
Sono rimasto quasi sconvolto nell’apprendere dell’esistenza di The Musical Box, una band canadese che riproduce i Genesis
fedelmente, dai vestiti agli strumenti (uno prestato direttamente da Rutherford), dalle scenografie alle luci, non tralasciando nemmeno le mosse e i discorsi tra una canzone e l’altra di Peter Gabriel.
Quando nel 73 sono venuti in Italia, il cantante dei Genesis HA DETTO le cose che ieri sera il cantante dei Musical Box ha ripetuto fedelmente, accenti, toni, errori grammaticali in italiano compresi.
Perché sconvolto?
Perché questa tendenza mi sembra esattamente quella che si è prodotta nella seconda metà dell’800 e ha segnato il passaggio dalla musica tout court alla musica classica:
Così cominciò anche ad emergere l’idea di musica classica; l’idea, cioè, che la musica di alcuni compositori del passato avesse un valore trascendente, che non fosse mero entertainment e quindi che dovesse essere ascoltata con grande attenzione e che dovesse essere eseguita esattamente com’era stata scritta.
E naturalmente anche i compositori del’800 cominciarono ad aspirare a scrivere musica del genere. Una musica che esprimesse sentimenti superiori, non un semplice divertimento. Una musica che li rendesse immortali, anche. E per il romanticismo, così pieno di nostalgia, di grandi ideali e di spinta verso l’assoluto, una concezione del genere era perfetta.
Citato in questo mio post
Detto da uno che insegna in una scuola chiamata Conservatorio, può far ridere (anche se insegno musica elettronica). Ma il fatto che una cosa del genere si palesi anche nella musica “pop” è un indice di decadenza assoluta. Attenzione: non si tratta solo di incapacità di innovare restando all’altezza del passato, ma anche di consapevolezza della propria incapacità di innovare. In altre parole, di resa.
Esattamente la stessa resa che si è manifestata in altre arti, per esempio con i pittori neo-rinascimentali, oppure, in architettura, qui da noi, con cose come la ricostruzione fedele del Teatro La Fenice a Venezia.
Perché, ragazzi miei, quando nel ‘700 crollava una chiesa che magari era lì da qualche secolo, pochi avrebbero pensato di ricostruirla uguale. Si sarebbe detto, invece, adesso la ricostruiremo nuova e più bella di prima, esprimendo fiducia nelle proprie capacità creative.
Con questo non dico che bisogna stendere una bella gittata di cemento sul passato (roll over Beethoven). Il passato va conservato, però il rifarlo uguale è indice della nascita di un culto (in senso culturale), anche perché dei Genesis di allora esistono dischi, filmati, registrazioni. Nulla è andato perso. Non è come il caso della musica classica di cui non abbiamo esecuzioni originali e ogni nuova esecuzione è un’interpretazione e un unicum.
Qui è peggio, perché non c’è interpretazione. Perché, notate bene, senza queste testimonianze tecniche (dischi, filmati), The Musical Box non potrebbe riprodurre pari pari, non solo la musica, ma anche l’evento (i costumi, le mosse, i discorsi, gli errori).
È la resa della creatività. È la chiusura del cerchio di Benjamin: l’opera d’arte, riprodotta tecnicamente, perde il suo status di unicità, per dirla con Benjamin, la sua “aura”. Ed ecco che proprio questa riproduzione tecnica viene usata da qualcuno al fine di riprodurre, fino ai particolari più secondari, quell’opera d’arte. Ma l’aura non può essere riconquistata.
Notate ancora una volta la differenza con la musica classica. Quando ascolto Michelangeli che esegue Beethoven, io, in cuor mio, non ascolto Beethoven, ascolto Michelangeli. In realtà, per me, Michelangeli non è Beethoven. Beethoven è la partitura, non l’interpretazione. Nella musica classica il messaggio viene trasmesso attraverso la partitura, non attraverso l’esecuzione perché ogni esecuzione è una interpretazione e la mia può essere diversa dalla tua. Così, anche quando sento per la prima volta un brano contemporaneo che mi piace, la prima cosa che penso è di vedere la partitura perché solo così posso capirlo e farlo mio.
Ma qui non è così. Qui ricadiamo nel caso della Fenice ricostruita. Il concerto di The Musical Box non è il concerto dei Genesis, è solo un tentativo di riconquistarne l’aura. E così è solo una pallida illusione, un simulacro dickiano.