Tempo fa, a uno studente che voleva sapere qualcosa di più su Stockhausen, avevo consigliato di leggere l’Intervista sul genio musicale, un lungo colloquio con il nostro, a cura di Myra Tannenbaum, Ed. Laterza, Bari, 1985.
Qualche giorno fa mi ha scritto che non si trova.
Incredulo, vado a cercare sulle più note librerie online e ha ragione: non si trova da nessuna parte. Allora vado sul sito dell’editore, cerco per titolo e mi esce “Nessun libro trovato”. Il vecchio effetto si ripete. I libri scompaiono, come in Fahrenheit 451 dove vengono bruciati, solo che stavolta a farli sparire non sono i pompieri, ma gli avvocati con il supporto delle leggi sul copyright.
Questo effetto combinato del mercato e del copyright è demenziale. Intere biblioteche composte da tutto ciò che è stato stampato, ma che non può contare su un mercato planetario, sono state ingoiate dal buco nero del copyright a causa di una legge che anni fa, tutto sommato, era ragionevole, ma che in seguito a una serie di estensioni, si è trasformata in un killer culturale.
Facciamo un esempio prendendo proprio il già citato Fahrenheit 451. Ray Bradbury lo ha pubblicato nel 1953. Secondo la legge dell’epoca, sarebbe diventato di dominio pubblico, al massimo quest’anno, nel 2010. Nel ’53, infatti, secondo la legislazione americana, il copyright si estendeva per 28 anni, con la possibilità di un rinnovo altrettanto lungo (totale 56 anni).
Questa possibilità dell’opt-in era molto importante. Dopo 28 anni, infatti, doveva presentarsi un editore intenzionato ad usufruire di questa opzione e quindi, si presume, a sfruttare commercialmente l’opera. In caso contrario, il copyright decadeva.
Era un buon sistema per far sì che le opere che avevano acquisito una popolarità duratura continuassero ad essere sul mercato, mentre per quelle di minore impatto mercantile, si aprivano le porte del pubblico dominio e della circolazione privata fra gli interessati. In effetti, questo era il destino del 93% dei libri, mentre solo sul 7% si esercitava il rinnovo.
Le estensioni approvate via via negli anni hanno portato la durata del copyright a sfiorare il secolo (se nulla cambia, Fahrenheit 451 entrerà nel pubblico dominio nel 2049), ma, cosa ben peggiore, hanno tolto la consuetudine dell’opt-in, per cui tutto è automaticamente copyrighted per il periodo fissato.
La cosa più assurda, comunque, è il fatto che il diritto permane anche se il detentore non fa nulla per rendere disponibile sul mercato l’opera. Questo fatto danneggia chi la vuol leggere, ma anche l’autore o i suoi eredi, che potrebbero, invece, cercare di ricavarne qualcosa.
Infine, l’unico modo in cui il mio studente può leggere l’intervista con Stockhausen è farsela prestare o, se vuole averne una copia, commettere un reato.
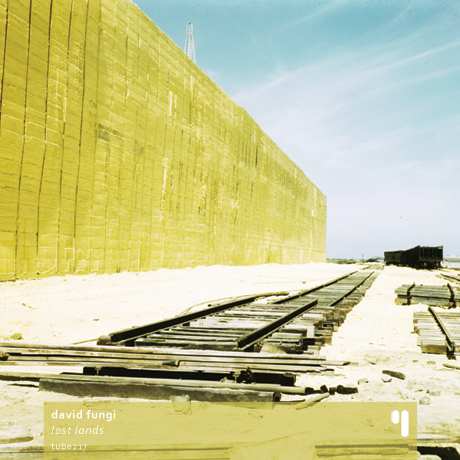


 Il 4 Gennaio di quest’anno è morto Tsutomu Yamaguchi (山口 彊, 16 March 1916 – 4 January 2010), una delle poche persone ad aver subito due bombardamenti atomici ed essere sopravvissuto.
Il 4 Gennaio di quest’anno è morto Tsutomu Yamaguchi (山口 彊, 16 March 1916 – 4 January 2010), una delle poche persone ad aver subito due bombardamenti atomici ed essere sopravvissuto.



